La mia suocera ogni volta mette una foglia di alloro sotto il cuscino di mio marito. Pensavo fosse una sorta di stregoneria… finché non ho scoperto la verità…
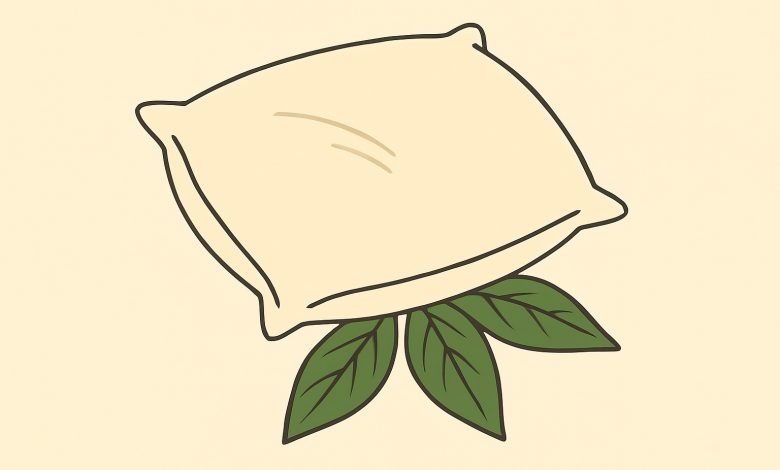
Ho esistato a lungo prima di chiedere, ma quella sera ho preso coraggio, mi sono avvicinata a lei in cucina e ho detto piano:
– Posso farti una domanda? Perché metti una foglia di alloro sotto il suo cuscino?..
Sembra che si sia fermata per un secondo — non spaventata, ma come se fosse stata riportata improvvisamente al passato. Poi si è seduta, ha appoggiato le mani sul tavolo e ha passato le dita sul bordo, come se stesse ricordando qualcosa di molto lontano.
– Non è un’idea mia, – ha detto a malapena udibile. – Lo faceva già la mia nonna. A me e ai miei fratelli.
Mi sono sorpresa, e lei ha continuato:
– Quando eravamo piccoli, avevamo spesso paura di notte. Ci svegliavamo per gli incubi, per il buio, per ogni rumore. E la nonna diceva: «La foglia d’alloro — per allontanare le paure». Credeva che il suo profumo fosse calmante, aiutasse a liberare la mente prima di dormire e alleviare la tensione. Ci diceva sempre: «Chi si addormenta con la mente serena si sveglia più forte».
Sorrise appena — quel sorriso tenue, quasi infantile, che fa capire che, mentalmente, è accanto a quella stessa nonna.
– La nonna credeva che la foglia d’alloro avesse tre poteri, – disse alzando tre dita.
– Il primo: calma chi è troppo preoccupato e tiene tutto dentro.
Il secondo: protegge il sonno — non per magia, ma per il suo profumo. Odora di casa, di calore, di cucina… e questo dà un senso di sicurezza.
E il terzo: funziona come un silenzioso augurio. La nonna, mettendo il foglio sotto il nostro cuscino, sussurrava sempre: «Che tu possa sognare qualcosa di bello».
Fece un respiro profondo e guardò verso la stanza, dove in quel momento dormiva suo figlio — mio marito.
– Quando era piccolo, – continuò la suocera, – era spesso assillato da paure notturne. Si svegliava urlando, piangeva, diceva che aveva paura. Ero sola, mio marito era spesso in viaggio per lavoro. E allora ho ricordato la nonna. Ho messo sotto il suo cuscino una foglia d’alloro, e per la prima volta dopo molte settimane, dormì sereno. Dopo tutte quelle notti tormentate… fu un miracolo.
Piegò le mani in grembo, e il suo sguardo divenne un po’ perso e tenero.
– Capisci… per me non è un rito né una superstizione. È il mio modo per dirgli: «Sono qui. Sei al sicuro». È un legame. È il ricordo di mia nonna. È il modo in cui so esprimere amore.
Mi guardò con un po’ di imbarazzo:
– So che lui è già adulto. Ma i figli crescono solo all’esterno. Dentro, restano comunque i nostri ragazzi. E se l’unico modo per prendersi cura del proprio figlio adulto è mettere sotto il cuscino una piccola foglia… allora sia.
Quella sera sono andata in camera e ho guardato a lungo quella semplice foglia d’alloro sul comodino.
Ho capito: non è magia. È il silenzioso, femminile, generazionale prendersi cura. Invisibile, ma reale.
E mi è passato per la mente un pensiero: avrò anch’io un mio piccolo «rito materno», che capiranno solo i miei figli quando cresceranno?
E voi cosa ne pensate — vale la pena mantenere queste piccole «tradizioni» familiari o bisognerebbe abbandonarle quando i figli diventano adulti?



